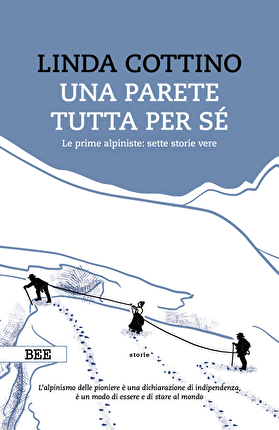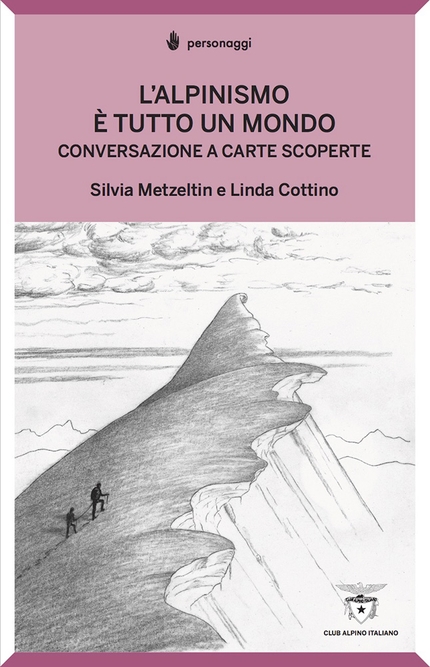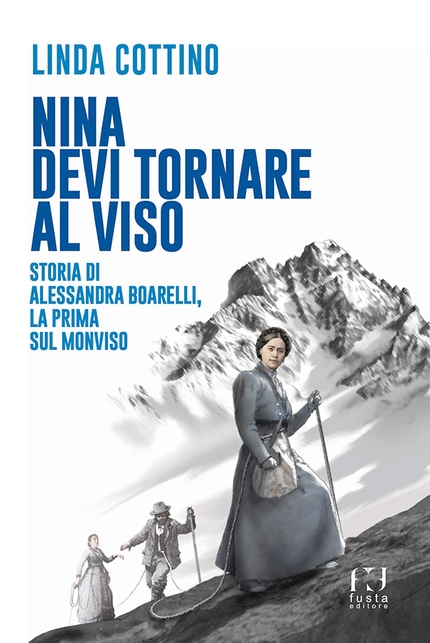Una Parete tutta per sé di Linda Cottino
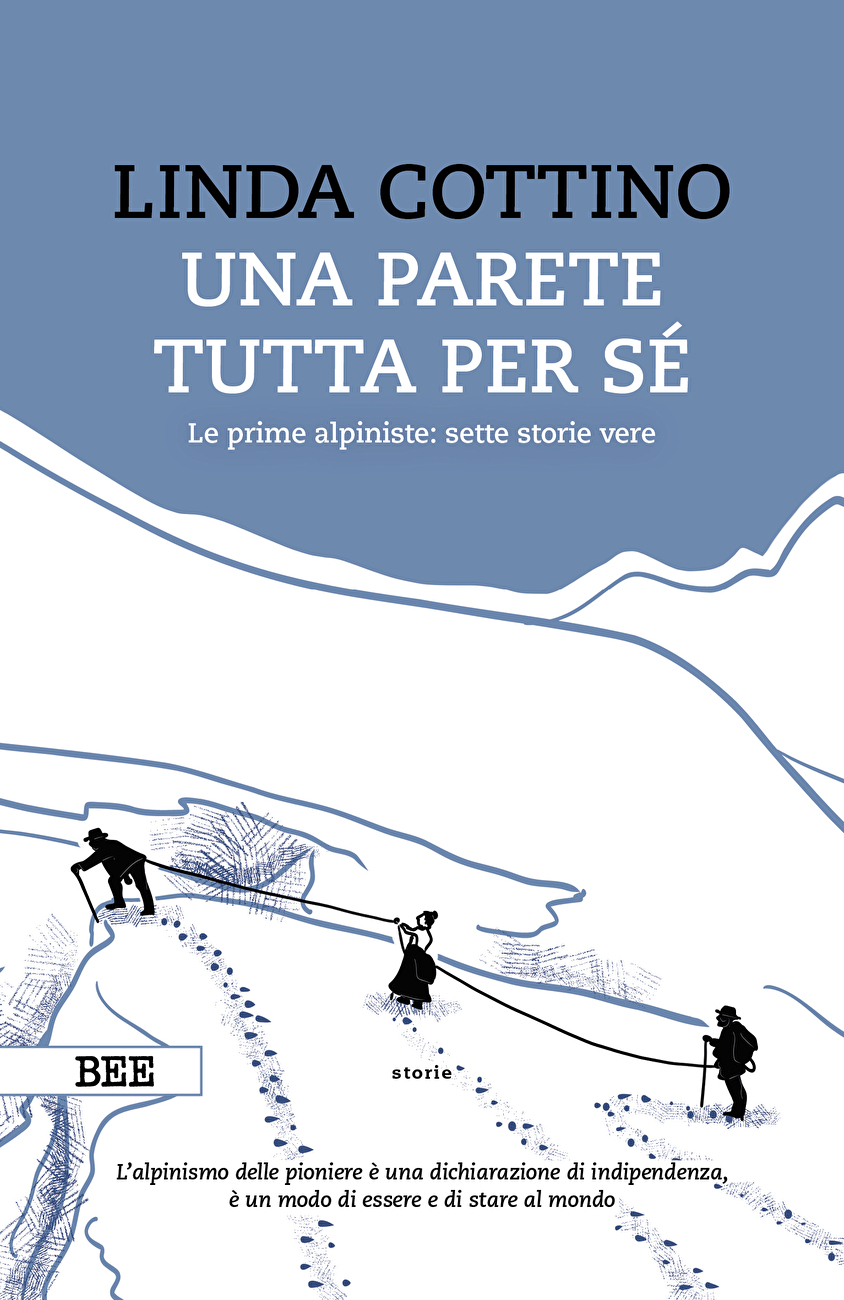
 1 / 1
1 / 1 archivio Linda Cottino
archivio Linda Cottino
alpinismo
/al·pi·nì·ṣmo/
sostantivo maschile
La pratica e la tecnica dello sport che ha come scopo la scalata delle montagne e delle pareti rocciose.
Così recita l’Oxford Languages. Eppure anche l’enciclopedia Treccani, prima di addentrarsi nelle specializzazioni di questa attività, fornisce una descrizione simile. alpinismo. s.m. dove l’abbreviazione esplicita anche qui per prima cosa la tipologia della parola: un sostantivo di genere maschile perché quasi da sempre, la gran parte delle attività umane sono nate declinate al maschile, eredità di una cultura che pensava che tutti quegli esercizi, funzioni, mansioni che richiedessero un serio impegno fisico o intellettuale dovessero essere svolte dagli esseri umani di sesso maschile. A questa regola non ha fatto di certo eccezione l’alpinismo con il suo vocabolario mediato da quello guerresco, dove il raggiungimento dell’obiettivo era sempre una conquista – parole che richiama, oltre che al successo di una lotta armata anche il raggiungimento dei favori di una dama.
Così, mentre l’uomo saliva le montagne per scoprire, esplorare, per ricerca scientifica e infine anche per il puro piacere di farlo, il genere femminile è sembrato per tanto tempo escluso da questo andare per le alte vette. La storia, quella dell’alpinismo narrato, dei recit d’ascension, dei volumi in cui erano raccolti i racconti delle salite sembra essere stata uomo-centrica, relegando le donne a semplici spettatrici dal basso, spesso timorose e tremanti per l’esito delle vicende legate a loro compagni alpinisti o al più, nei casi in cui venivano coinvolte in salite, a soggetti da condurre legate al guinzaglio di una cordata.
In realtà, nella storia reale dell’alpinismo, fin dai primordi di questa attività, il genere femminile ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre maggiore, perché la voglia di esplorare e di vivere emozioni non poteva e non può essere relegata solo a metà del genere umano.
Questa parte di storia però, benché narrata, è stata spesso confinata quasi a un fatto folcloristico, come se le salite di queste donne fossero imputate più a capricci che a una reale esigenza: così, le vicende alpinistiche dell’altra metà del cielo frequentemente non sono contemplate nella storiografia ufficiale, nonostante la loro indubbia importanza al momento della realizzazione e nel ciclo complessivo delle vicende che hanno visto l’evoluzione dell’alpinismo.
E’ bene ribadire che nonostante esistano differenze fra uomini e donne, fisiche e psichiche, queste da sole non bastano per considerare una qualunque parte del genere umano superiore all’altra o non adatta a una particolare attività.
Il volume di Linda Cottino prova quindi a ricostruire tasselli di questa parte di storia negata dell’alpinismo, dando voce proprio ad alcune delle protagoniste della prima fase di quelle vicende che hanno spinto il genere umano verso le vette: il genere umano tutto, non i soli uomini o le sole donne. Per fare questo ecco che Linda Cottino ci racconta attraverso gli occhi e le parole di queste protagoniste – perché questo è il ruolo che hanno avuto, non quello di comprimarie o accompagnatrici – quale è stata la strada percorsa per divenire padrone del loro andare in montagna. Figure del mondo anglosassone e statunitense ma anche francese, tedesco, italiano, dell’estremo oriente quelle raccontate o solo citate, perché come è stato per la parte di storia alpinistica dell’uomo, anche per la donna la voglia di salire non ha avuto e non ha confini. Una voglia di essere padrone del destino sulle pareti che ha condotto queste pioniere a formare cordate di sole donne, a sottolineare l’indipendenza dall’uomo certo e quindi anche la capacità, volendo, di poterne fare a meno. Il pregio, inoltre, delle vicende narrate nel volume Una parete tutta per sé – nome mediato da quello del saggio di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, manifesto sulla condizione femminile nel mondo della letteratura e della sua esclusione da esso - è quello di poggiarsi su un lavoro di ricostruzione e ricerca con pochi eguali, con una documentazione raccolta nelle maggiori e più importanti biblioteche dedicate all’alpinismo che non viene elaborata secondo i modelli della scrittura di eventi storici. No, qui le vicende vengono raccontate dalla viva voce delle stesse protagoniste, secondo i moduli del classico recit d’ascension permeato però da quella sensibilità femminile che porta le emozioni in prima piano non esagerandole ma donandole come semplice condivisione del vissuto. Qualcosa che i racconti delle salite fatte dagli uomini spesso non avevano e non hanno, cedendo alla voglia di rendere le loro salite qualcosa di epico: come qualcuno ancora oggi pensa possa essere un conflitto o la guerra.
A chiusura del volume, sorge il pensiero che probabilmente una nuova storia possa e debba essere non solo raccontata ma soprattutto vissuta nel mondo dell’alpinismo come in quello di tutti i giorni. Quella in cui le due parti del genere umano possano dare il medesimo contributo alle loro vicende. Perché al di là delle differenze che esistono fra i due sessi, sempre più spesso viene da pensare che queste siano complementari, compensative dei due differenti stati d’essere, tanto che l’unione di una più uno possa non dare come risultato due, ma qualcosa in più della semplice somma delle unità: una cordata dove l’intimità delle due essenze porti a un livello superiore l’intero genere umano.
di Alberto Sciamplicotti
Una Parete tutta per sé
Bottega Errante Edizioni
17 Euro
ISBN 979-12-55670-53-7
Il primo alpinismo delle donne è una dichiarazione di indipendenza, è un modo di essere e di stare al mondo: Meta Brevoort, la prima grande esploratrice e pioniera sulla Meije nelle Alpi del Delfinato; Marie Paillon, la prima intellettuale della montagna e tra le prime a far cordata femminile con la fortissima Kathleen Richardson; le sorelle Pigeon, con una prima al Monte Rosa; Elizabeth Aubrey Le Blond, fondatrice del Ladies’ Alpine Club. Che cosa poteva mai spingere una signora dell’alta società a uscire dal recinto domestico-familiare assegnatole per avventurarsi nel duro ambiente alpino e misurarsi con il ghiaccio e le pareti di roccia, spingendosi sui passi d’alta quota e fin sulle cime delle Alpi? Forza, audacia e ambizione erano qualità precluse alle donne.



 Copia link
Copia link